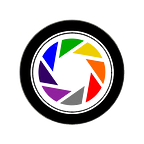Jen Davis è una fotografa newyorchese di 34 anni, abbiamo parlato del suo lavoro in un articolo di Ottobre: Jen Davis | Autoritratto dell’essere.
Nel 2002, a 24 anni, la Davis per la prima volta scatta un autoritratto: su una spiaggia del South Carolina prende il sole insieme ad un’amica, pesa 120 chili. “All’inizio, volevo solo vedere come il mondo esterno mi vedeva”, è la prima foto di una ricerca che la impegnerà per 10 anni e la porterà a riflettere sui temi dell’identità, della propria immagine nel mondo, della bellezza e anche del desiderio e della sensualità.
Jen Davis e la ri-costruzione fotografica
Un lungo percorso con svolte e prese di coscienza documentate e percepibili che trasmettono all’osservatore quel disagio che proviamo solo davanti ad un’anima che si rivela.
Dopo quel primo scatto spontaneo comincia un lavoro di ri-costruzione della vita a favore dell’obbiettivo: “Ho costruito un rapporto con la macchina fotografica nel quale ho trasformato l’atto di scattare una fotografia in una performance per l’obbiettivo.”
Questa performance cerca di rappresentare momenti che segnano la difficoltà della Davis a convivere con il suo corpo, la foto “Push-Up Bra” del 2003 è scattata a casa di un’amica e nell’intenzioni dell’artista è un modo per superare il disagio di doversi spogliare in un ambiente estraneo.
Ma il vero scoglio da superare è uscire allo scoperto: in una camera oscura comune la Davis si ritrova a coprire parte di questa foto (quella in cui si vede il suo corpo) con un pezzo di carta “Voglio veramente mostrarmi così?”, si chiede. Ci mette una settimana per decidere, ma alla fine questa diventa la sua “anchor picture”, il momento della svolta e della presa di coscienza, lafotografia non è più solo un mezzo di self-healing e accettazione ma anche uno strumento di espressione e di confronto con la società, “una società che giudica la bellezza in base all’aspetto fisico”.
Se è con la società che si vuole confrontare il luogo delegato per questo confronto è la casa. L’intimità dello spazio personale la protegge dall’esterno e le permette, nascondendola, di mostrarsi davvero. Molta forza di questi ritratti viene dell’ambiente in cui sono scattati: anche se la Davis prepara un “personal stage” per le sue performance, è un palcoscenico di oggetti personali e quotidiani, le sue quinte sono porte, finestre, pareti e tende. Questaorchestrazione dello spazio domestico è sottile ed incisiva, colpisce l’osservatore sul piano estetico per l’armonia e l’equilibrio di forme e colori, e sul piano emozionale presentandogli undejà vù – lo spazio privato – che ognuno di noi riconosce come contenitore del nostro io più vulnerabile.
Gli autoritratti o self portrait che dir si voglia
Nel 2004 gli autoritratti diventano anche materializzazioni delle fantasie dell’artista, momenti di intimità con uomini che, per via del suo peso, si sente di non poter avere nella vita reale.
Fantasy n°1 è una di queste foto: una luce caravaggesca illumina il viso di Jen – che guarda con intensità direttamente in camera – e l’abbraccio; tutto il resto è avvolto nel buio, compreso il volto e il corpo dell’uomo. In questo modo la fotografia ci trasmette il desiderio di quell’abbraccio come sentimento puro, una pulsione umana verso l’affetto e la vicinanza con un altro essere umano e nello stesso tempo ci comunica il rimpianto per una condizione che è solo sognata e non reale.
Continuando a scorrere le foto e le date nel 2007 si avverte, finalmente, una maggiore sicurezza e rilassatezza nel rapporto tra Jen e il suo corpo.
Nel corso degli anni sono diventata più audace nelle foto e ho rivelato di più, fisicamente, esposto più pelle. A spingermi era anche il fatto che si trattava di un lato di me che non mostravo mai, che non usciva, il mio lato privato ed intimo che il mondo esterno non poteva vedere. … Un lato che non riuscivo ad esprimere né di cui riuscivo a parlare. L’unico modo di riuscire ad articolarlo in qualche modo era attraverso la macchina fotografica, per [tirar fuori] le insicurezze e la vulnerabilità che implicava.
La ritrovata identità di giovane donna trasforma questi scatti in una presa di posizione critica contro l’immagine dominante della donna e i modelli di bellezza, e la loro autenticità convince e coinvolge l’osservatore in questo processo.
L’identità tra fotografo e modella amplifica la forza di questi scatti, essi non sono pensati per altri occhi se non quelli dello spettatore, il gioco erotico che talvolta avvertiamo tra modella e fotografo qui si azzera e ci ritroviamo davanti la visione di un momento intimo e segreto confezionato solo per i nostri occhi.
Dopo questa presa di coscienza gli ultimi scatti, tra 2010 e 2011, ci appaiono come “alleggeriti”, ho cercato motivi formali che spiegassero questa sensazione, ma non ne ho trovati, dal punto di vista stilistico l’opera della Davis è omogenea con una grammatica visiva ben definita e costante. Le sensazioni di disagio, solitudine, accettazione, desiderio, vulnerabilità, forza e ricerca di sé che lo spettatore percepisce sono il risultato di un lavoro che l’artista compie su se stessa, traspaiono senza bisogno di metafore, si impongono senza mediazione e movimentano un viaggio interiore, un percorso di sofferenza e crescita che ci trova partecipi dalla prima all’ultima fotografia.
I ask in exchange
Prima di concludere voglio solo nominare l’opera seguente della Davis “I ask in exchange”. Anche qui l’utilizzo della macchina fotografica come mezzo di relazione con il mondo esterno è preponderante. Anzi, la consapevolezza raggiunta tramite gli autoscatti produce la voglia di aprirsi all’altro – all’elemento maschile, desiderato, immaginato e mancante.
Il viaggio ricomincia, ma questa volta si tratta di un viaggio reale attraverso l’America, di un’esplorazione del mondo.
Non più protetta dalle pareti domestiche le rimane solo la macchina fotografica dietro cui ripararsi, da usare quasi come un’arma per affrontare l’universo maschile.
“I ask in exchange” è una collezione di ritratti di uomini, uomini che la Davis non conosce, uomini che incontra durante il suo viaggio e che riesce ad approcciare solo grazie alla fotografia. La fotografia è il dono, il pretesto, quello che chiede in cambio è l’intensità dei loro sguardi, l’intimità di poche ore, l’impressione di essere guardata e desiderata.
Quello che mi affascina di Jen Davis è che il suo percorso artistico e quello umano coincidono e rappresentano il cammino di riconoscimento e affermazione di sé attraverso il quale ogni individuo deve passare, di approccio al mondo, alla sessualità e all’altro verso cui tutti tendiamo.
Oggi Jen Davis ha 34 anni, sono curiosa di seguire questa giovane donna per vedere come si evolverà, maturerà e continuerà a documentare il suo passaggio nel mondo.
Laureata alla Columbia e con un master a Yale oggi Jen insegna fotografia e continua la sua personale ricerca espressiva focalizzata soprattutto sull’autoritratto e sul ritratto. Abbiamo incontrato Jen Davis su Skype per parlare del suo lavoro di fotografa, e del suo rapporto con la fotografia come mezzo espressivo. Questa è la prima parte della sua intervista.
2Photo: Self-Portraits è (finora) il tuo lavoro più conosciuto e completo. Un ampio portafoglio iniziato nel 2002, quando avevi solo 24, che continua tutt’ora. Vuoi parlarcene? Come hai deciso di puntare l’obbiettivo su te stessa?
JEN: Ero ancora all’Università – alla Columbia, e prima di cominciare con gli autoritratti, prima di essere in grado di puntare l’obbiettivo su me stessa, fotografavo altre persone. Fotografavo una persona per semestre e cercavo di mettere insieme un lavoro che parlasse di isolamento e solitudine. Li guardavo e per me queste persone erano i miei surrogati, erano autoritratti senza me nella foto, usavo queste persone per interpretarmi. Li portavo avanti per tutto il semestre ma alla fine mi sentivo frustrata, perché non sapevo mai come sarebbe progredito il lavoro … e le persone si stancavano, perché pretendevo così tanto da loro, anche tanto tempo. E così l’ultimo semestre del mio ultimo anno ho deciso che avrei dovuto accettare il rischio e puntare l’obbiettivo su di me, cercare di scoprire che cosa stavo cercando, in me stessa e nel mio lavoro.
2Photo: Cito le tue parole, hai detto: “La fotografia è il mezzo che uso per raccontare la mia storia attraverso la vita …” Perché hai deciso di esprimere i tuoi conflitti con questo mezzo?
JEN: Credo che sia stato perché ero già molto presa da questo mezzo e così interessata a scattare foto. Ero ad un punto dove a 23 anni e non sapevo chi ero, è stato più facile per me per iniziare a conoscermi tramite la macchina fotografica. Non ero in grado di parlarne a voce, del mio corpo e del modo in cui era visto dalla società – mi sarei bloccata e messa a piangere. Però mi sono resa conto che si trattava di qualcosa che avevo bisogno di capire e risolvere in qualche modo ed il passo successivo per me è stato girare l’obiettivo su di me. Il lavoro è cominciato come un semplice confronto, mi paragonavo con le altre persone cercando di capire come il mio corpo potesse rientrare [nei canoni socialmente accettati] – e non poteva, non si adattava al tipo di bellezza ideale della nostra società, all’ identità standardizzata, una cosa che non sapevo nemmeno esistesse e non riuscivo a concepire. E’ stato solo grazie al mio rapporto con la macchina fotografica che ho potuto affrontare questi sentimenti di isolamento e queste riflessioni sulla mia immagine e la percezione che ne avevo.
2Photo: Quello che mi stupisce è che a dispetto della lunghezza del progetto il tuo stile è ben definito e si presenta omogeneo fin dall’inizio. Avevi già in mente che tipo di fotografo volevi diventare? Hai qualche modello o ispirazione?
JEN: Quando ho iniziato a fare questo lavoro ero una fotografa di bianco e nero. Prima dei Self-Portraits, mentre lavoravo ancora con le altre persone, ho ricevuto alcune polaroid a colori in omaggio; ho preso l’esposizione e le ho provate … ho “tirato” e ho visto i colori e … “wow ” la scala cromatica era molto soft, quasi monocromatica, non avevo visto i colori in quel modo da molto tempo. Così, quando ho deciso di iniziare a fotografare me stesso ho pensato “Ho bisogno di vedere questo lavoro a colori, ho bisogno di vedere come appaiono le mie guance, la mia pelle, e come sono davvero, a colori…” La mia paletta di colori e la luce sono state importanti, sono sempre stata attratta da questi elementi: da una tavolozza soft, e dalla luce calda, la luce del giorno, la luce della sera che passa attraverso [i vetri], “l’happy hour”, la “golden hour”… queste cose mi hanno sempre ispirato e ancora oggi lo fanno, i gialli, i blu e tutte le sfumature di scale cromatiche morbide. Inoltre, mentre il progetto progrediva – dopo uno o due anni – ho capito che stavo usando i colori e la luce per cercare di sedurre, cercare di fare qualcosa di bello e prezioso grazie ad una paletta di colori morbidi e all’uso della luce soft, per restituire un’immagine bella e seducente di qualcosa che non è era necessariamente visto come bello e seducente. Ottenere l’interesse dell’osservatore grazie alla bellezza formale.
2Photo:Hai detto: “Ho costruito un rapporto tra me e la macchina dove trasformo l’atto di fare una fotografia in una performance per macchina fotografica.” Come fai a scegliere cosa esibire davanti all’obiettivo? Quale parte della tua esperienza personale ri-costruisci in fotografie?
JEN: Mi sembra che quello che posso esibire per l’obiettivo, questa specie di messa in scena, sia la parte di me più privata e che normalmente non tiro mostro nella vita quotidiana… la proiezione di un sé privato che non sapevo nemmeno di avere. Affrontavo questa solitudine, questo senso di isolamento e questo mio mondo interiore usando lo spazio del mio appartamento. Riflettevo molto, prima di impostare la macchina fotografica; la luce dettava lo spazio, il modo in cui entrava nell’appartamento. Organizzavo lo spazio e quello sarebbe stato il mio palcoscenico, la cornice della foto era il mio palcoscenico, spesso il ruolo che recitavo era un lato della mia personalità, un lato privato. Pensavo ad un rullino, e mi preparavo 10 scatti per ogni scena, avevo un’idea, una specie di scaletta: “questo è quello che voglio scattare” … facevo 4 o 5 foto dall’idea iniziale e poi il resto degli scatti lasciavo che le cose accadessero, facevo cose diverse sperimentavo. Ed è lì che ho capito che questo spettacolo che stavo creando per la macchina fotografica svelava un autentico lato di me stessa.
2Photo: Così quando non seguivi l’idea originale era anche meglio …
JEN: A volte sì, permetteva una sorta di libertà, una sorta di apertura alle possibilità. All’inizio inoltre scattavo con il banco ottico, e l’operazione era molto più organizzata. Scattavo 2 o 3 fogli di pellicola per scena e il rigore di esecuzione doveva essere maggiore di quello che ho appena descritto … così spesso era tutto programmato, ma a volte – si sa – succedevano cose che mi prendevano di sorpresa e da quelle ho imparato.
2Photo: Tu scatti utilizzando ancora la pellicola. Perché preferisci analogico al digitale?
JEN: Mi piace non sapere quello che sto scattando, quello che sto facendo. Mi piace la qualità, il risultato … al momento la qualità non è paragonabile. Chi lo sa, forse un giorno, potrebbe essere un’opzione … ma per ora mi piace non sapere, non vedere, mi piace l’atto di preparare la macchina fotografica ed il processo di sviluppo delle pellicole … portare i miei rullini a sviluppare, aspettare ed essere sorpresa dal risultato…
2Photo: C’è più magia …
JEN: Si, c’è più magia. E quando lavoro con altre persone facendo i loro ritratti, nemmeno loro possono vedere [subito le immagini]. Non mi piacerebbe che il rapporto finisse lì, semplicemente con: “fammi vedere” … Il potere del fotografo nei confronti dei soggetti cambia quando questi hanno il privilegio o il diritto di vedere e di – in un certo senso – criticare; mentre tu stai solo cercando di lavorare e di produrre qualcosa, di capire qualcosa.
2Photo: Tu hai un senso della luce e della composizione molto sviluppato, è il risultato di uno studio? Presti molta attenzione a questi aspetti quando imposti una foto?
JEN: E’ già tutto nella fotografia mentale che ho in testa: il modo in cui la luce arriva, il modo in cui i colori vengono accostati. Molte volte centra anche la scelta dei vestiti, quelli che funzionano meglio in quella camera, con quel colore. Tutto è predisposto, ogni elemento è controllato: i mobili vengono spostati, le cose rimosse, solo per la fotografia … E la luce per me è l’elemento più importante, è la cosa più emozionante … nella fotografia o nella vita reale. E’ sicuramente una delle mie più grandi influenze, anche al di fuori della fotografia riesce a provocare una reazione emotiva ad innescare una connessione; posso sentirla ed apprezzarla … ecco, credo che sia una forma di apprezzamento, sono in grado di sentirla, e vederla finché riesco ad associarla con un ricordo, la memoria di un luogo. C’è qualcosa di molto speciale per me in questo.
2Photo: Ecco perché la usi così bene, in un certo modo la senti …
JEN: Sì, è così, ne parlo in continuazione… (ride)
Per saperne di più e vedere i suoi lavori: jendavisphoto.com
Published on 6 october 2012 http://www.2photo.org/jen-davis-autoritratto-dellessere/
Published on 17November 2012 http://www.2photo.org/jen-davis-autoritratto-dellessere/